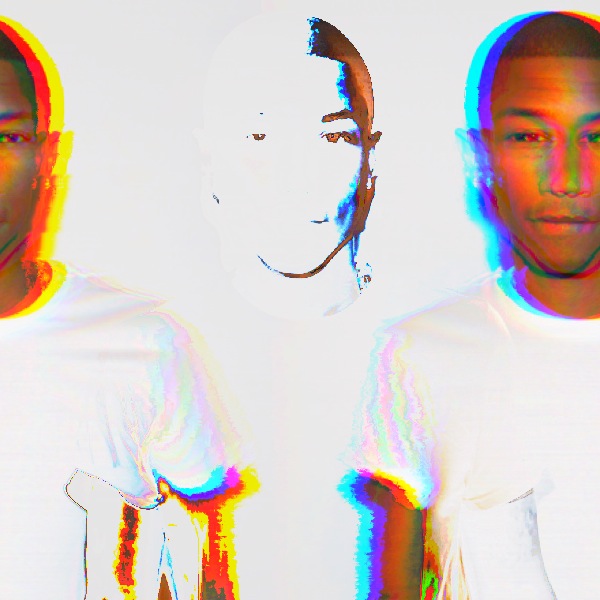
Cercherò di non dilungarmi, perché se avessi voluto scrivere cartelle word a profusione avrei proposto una review-back per la tardiva, morbidamente sommaria, delicatamente schiva, scrupolosamente piagnona, e rigorosamente bianca recensione che Rolling Stone ha pubblicato per l’ultimo album di Beyoncé. Aggiungo: sia chiaro che ho intenzione di censurare il nome Michael Jackson in questo articolo per semplici motivi quali l’abbondante esondazione scrotale dovuta all’abuso fatto da giornalisti d’ogni foggia del nome stesso, tirato in ballo anche dove Michael stesso non avrebbe saputo come ballare , o quel vezzo naïve di indicare col nome Michael Jackson un genere musicale un po’ confuso che dovrebbe abbracciare 40 anni di carriera comprendendo escursioni musicali che vanno dal funky motown, all’african tribal, dal synth n blues al duetto con Akon. Fatte premesse, pulite le mani e citata Beyoncé a cazzo, arrivo subito al sodo della questione: ma di Pharrell, nel 2014, cosa dobbiamo farcene? A questo punto è chiaro che l’articolo sia rivolto ad un pubblico in possesso di certi strumenti, un pubblico che conosca ad esempio la discografia di Kelis, che abbia familiarità, magari latente, col nome Chad Hugo, che non storca il naso se dovessi arrivare a dire che Britney Spears attualmente ancora conserva tra le mani il singolo pop migliore del corrente secolo (in fondo, il corrente secolo, ad ora conta solo 14 anni, nei quali poi più di tanto in fatto musicale non è che sia successo). Indiscutibile che lo zigomo d’oro della Virginia abbia vissuto lo scorso anno una fulgida impennata che nonostante la gloriosa carriera ventennale un po’ gli serviva per rialzarsi da una manciata d’anni scanditi da lavori menati alla sans façon. Anni nei quali ha dovuto digerire lo smacco per un debut album voluto, rilasciato e poco acclamato, quasi dimenticato. Un album anche audace, ambizioso, In My Mind, trainato da singoli maledettamente radiofonici, ma non stucchevoli come quel babà spugnato di Happy, bensì sfacciati e superbi (Can I Have It Like That, Number One), dichiaratamente sintetici nei suoni e valorizzati da guest di prim’ordine (Gwen Stefani, Kanye West).
Un’esercitazione di stile che era solo il coronamento di una evangelizzazione musicale su scala enorme, In My Mind meritava di brillare nel firmamento dei testi sacri incisi su compact disc. E invece è finito nel limbo dei “sarà per la prossima, dai”, nonostante, scavalcati i singoli super-catchy, una selva di post-sperimentalismo, assuefacente cacofonia e raffinatezza brutale ricopriva le restanti tracce contenute nell’album. Negli anni precedenti al rilascio di In My Mind, Pharrell, insieme al socio Chad Hugo, forgiava i più pregiati manufatti della musica mainstream early ’00, disseminando percussioni ora funkish ora metalliche, falsetti pregiati e gli inconfondibili intro taglia e incolla per gli artisti più blasonati del pop, da Justin Timberlake a Snoop Dogg, da Kelis a Jay Z. Il passo verso la pubblicazione del primo album da imperatore della musica contemporanea era imprescindibile. Ma l’eccessiva spinta autocelebrativa, sebbene legittima, ha reso il progetto ostico per il pubblico anche più fedele. Nell’oceano di produzioni alimentato fino al 2006, una goccia oggi vale la pena di riscoprire, è il singolo Wanna Love You Girl di Robin Thicke, lanciato nel 2005, per cui, badate bene, l’anno precedente l’uscita di In My Mind.
Il giovane Thicke canta un ritornello ridondante e seducente, registro basso ed eleganza da far saltare via i reggiseni, accompagnato da archi pizzicati in modo veloce e teso come se le corde fossero bollenti. La stessa identica modalità di trattare gli archi la ritroviamo in Marylin Monroe, traccia d’apertura della seconda fatica discografica di Pharrell, G I R L. In Wanna Love You Girl a far da contrappeso agli archi c’erano grandi percussioni ben riverberate ed effetti da tastiera stesi a stemperare la melense seriosità.
In Marylin Monroe, invece, i vari layer tessuti dagli archi vengono disgraziatamente sepolti sotto la mediocrità di una chitarrina funky che nel 2014 ha davvero, per essere pragmatici ed incisivi, rotto i coglioni. Ma nel 2014, diciamocela tutta, a rompere i coglioni è proprio tutta questa ondata revival che pare debba essere la tomba dell’istinto creativo, il capezzale della sperimentazione; e G I R L ne è mausoleo. Non è comunque il caso d’essere estremisti: Gush, quarta traccia dell’album, è una delle poche oasi felici incontrate durante la traversata della tracklist, in cui la mente gioca a rievocare le atmosfere di Frontin’, anche se qui il tutto si fa più stridulo, e viene stimolata dalla citazione della gloriosa Light Your Ass On Fire (Busta Rhymes).
Preludio a G I R L sono di certo la felice esperienza dei Daft Punk e il successo del singolo Blurred Lines di Robin Thicke (l’ormai anzianotto Thicke torna a precedere di poco un album di Pharrell con un proprio singolo, dallo stesso prodotto, così come nel lontano 2005). Mentre l’avventura con i Daft gli ha offerto l’occasione per sfoggiare un cinismo tale da allontanarlo da ogni nuovo stimolo per scegliere la strada della nauseante maniera, la goliardica collaborazione con Thicke gli ha regalato l’immagine de “la popstar che ormai c’ha un’età”. Non che la maniera di far musica revival fosse a lui estranea, anzi, ricordiamo un riuscitissimo tentativo di gettarsi nell’ondata retro delle canzonette Mark Ronson-inspired con il singolo I Decided confezionato per Solange Knowles (2008). Siamo arrivati forse così a rispolverare quello che era il prototipo di Happy.
Ma cosa è andato storto con quest’ultimo singolo dell Pharrellone mondiale? Un brano indubbiamente catchy, solare, positivo e calamitante, eppure il sottoscritto già da mesi cerca d’evitare accuratamente ogni tipo di rapporto con la suddetta canzonetta. Perfetta per essere colonna sonora di un film d’animazione, ma di certo non abbastanza per anticipare un album che forse avrebbe avuto tutt’altro appeal se il 2013 non fosse esistito. L’ansia di voler proporre qualcosa di troppo innocente per non funzionare ha pervaso lo spirito ideativo di un Pharrell molto più provocatorio ai tempi dell’album di debutto, e ad oggi sedotto da una mediocrità tesa al ritornello bonariamente ingenuo. Non è comunque tutta noia ciò che negli ultimi mesi il principe delle radio ci ha offerto, già agli sgoccioli dell’anno scorso, una monumentale Superpower viene modellata per le abili voci di Beyoncé e Frank Ocean, e una viscerale danza tribale viene riservata per l’album G I R L nella traccia Lost Queen. Cosa davvero quindi è snervante all’interno di questa seconda fatica discografica? La monotonia delle ispirazioni? L’estrema educazione nel comporre? La mancanza di un afflato inedito? L’ossessione dell’essere radio-friendly? O magari siamo noi che plagiati da troppo sad rap, da Drake, Kanye, The Weeknd, non riusciamo più ad apprezzare un lavoro che ha come sola pretesa quella di essere positivo e luminoso? Nel dubbio, impreco.




