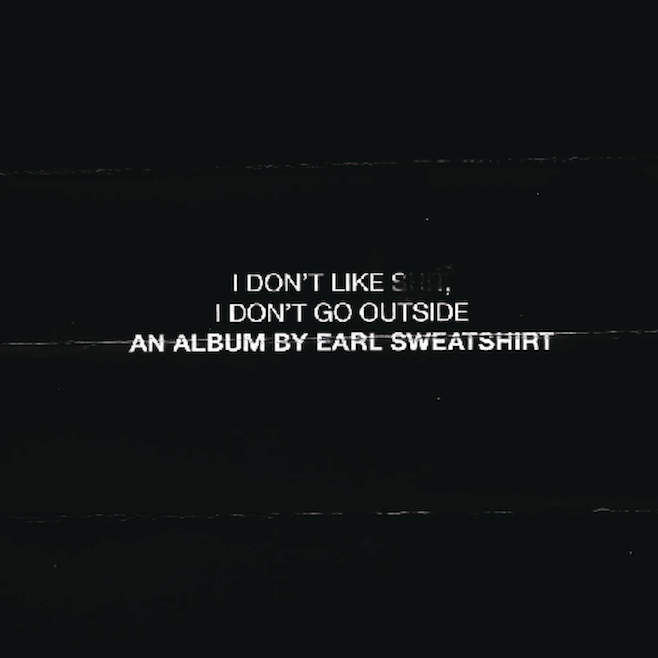
“Non mi piace quella roba, non ci vado là fuori”. Sembra lo sfogo di un ventenne stanco, strafatto e troppo ricco di idee per sentirsi mai realizzato. Beh, lo è.
Il titolo del secondo album di Earl Sweatshirt sulla propria etichetta (distribuito da Columbia) comprime, riassume e racchiude ogni sfaccettatura della sua persona.
L’esagerato sadismo di EARL (2010), mixtape registrato in piena adolescenza, sbiadiva già in Doris, esordio acclamato per lo slancio sperimentale dei beat e profondamente incentrato sull’arguzia verbale del ragazzino tornato dall’esilio in un collegio samoano. Esasperando i lati più escandescenti della sua personalità, si è creato con successo un personaggio che nel 2015 non è più sicuro di voler rappresentare. Ora, i giochi di parole non sono assenti, ma in parte sacrificati in favore di una precisa delineazione dei suoi sentimenti, percepibile nel tono con cui sale in sella alle basi.
Annega in bottiglie e fumo (Huey, Mantra, … e tutte le altre) i dissapori che lo allontanano sempre più dalla Odd Future, crew divenuta fenomeno mediatico mondiale proprio il giorno in cui uscì il primo video di Sweatshirt. Non può però peccare di ingratitudine, poiché è grazie a Tyler the Creator e compagni che quelle mazzette verdi gli pesano in tasca. Mantra serve anche da aspro memoriale ad una relazione finita, raccontata in un linguaggio malinconicamente crudo. Earl rallenta il tempo più del possibile e in Faucet vorrebbe addirittura riavvolgerlo, per tornare a quando il suo viso valeva quanto gli altri. Stupire e continuare a farlo è complesso quando ci si aspetta ora parole inventate, ora concerti infiniti, ora buon viso a cattiva intervista: mentre la remota idea di voler impressionare il padre, poeta africano che lo abbandonò a sei anni, è subito rinnegata, il fallimento amoroso lo tormenta come affligge il più comune dei giovani umani.
I messaggi che invia a fan e nemici sono inequivocabili, i suoi neuroni armi senza sicura: la metafora più semplice in assoluto, riverberata e sfumata da una cassa all’altra come farebbe l’amico e frequente collaboratore Mac Miller, è un allerta per qualunque cosa abbia in serbo, in questo istante come tra dieci anni.
Grief, primo e improvviso singolo tratto dal disco, è un tenebroso e maturo flusso di coscienza. Il ritornello è una sorta di breve strofa reiterata (tipico, svogliato Earl), il beat è ghiaccio, vetro e vapori vari. Il flow varia a metà canzone, come se le sostanze stessero silenziosamente rimarginando mancanze, fino a bruciare tutto per creare nuove follie: l’allegro outro campiona Gary Wilson, genio solo in parte compreso e sperimentatore di quel psych-rock anni ’70 percepibile tra le influenze di I Don’t Like Shit: un elogio alla disarmonia, in sostanza. Negli scorci più sereni è facile il paragone con altri nomi della new school, soprattutto chicagoani come Saba, Chance The Rapper, Mick Jenkins.
Chicago non è la città di Earl, e non lo è nemmeno LA, ormai. Non sa più che cosa significhi “chiamare a casa” (Faucet), il mondo è angusto, paure e cenere stringono le pareti tutto intorno. L’annebbiata sofferenza sale nelle sue corde vocali dai polmoni, per poi scendere e ritornare in alto, senza tregua né sobria soluzione.
Meno pitchata e filtrata del solito, la voce è spesso sovrapposizione di più tracce, con Tyler ospite nascosto in Off Top, uno dei due brani centrali prodotti da Left Brain (Odd Future), mai eccezionale nelle sue atmosfere stranianti, ma qui in buona sintonia con le intenzioni comunicative del rapper. L’altra sua produzione è Grown Ups, in cui Earl condivide ansiosi dubbi e duri istinti con il collega Da$h, MC del New Jersey che funge da interlocutore in un nevrotico viaggio.
Escluse le sopracitate, ogni base dell’album esce dalle mani di Earl stesso. Immancabili le melodie less-is-more e i synth giocosamente fai da te, gli stessi elementi che hanno reso Yonkers e il resto del catalogo OF così accessibile a quindicenni vulnerabili come a trentenni alternativi. La più intensa e regolare è AM, pezzo che ha più che un retrogusto del miglior Alchemist, con il basso protagonista e pilota della struttura. Wiki, leader dei Ratking, ha la tenacia dei più grandi rapper newyorkesi, e la tecnica per inseguire il Wu-Tang Clan a testa alta. Il padrone di casa risponde con le assonanze più aggressive dell’intero LP, spiegando perché i vostri amici indossano Supreme e come abbia imparato a rimare solo dopo le sbucciature sullo skate.
Proprio uno skater professionista (sponsorizzato da chi, secondo voi?) sputa una strofa sul beat di DNA, una sorta di frettoloso requiem per morti precoci. La comparsa dell’amico risulta più opportuna del previsto: pur non avendo le doti di un artista hip-hop vero e proprio, Na’Kel Smith porta una testimonianza autentica, inserendosi nel progetto come in un non censurato backstage della gioventù di due ventenni di successo.
Il rapper più puro – e forse più atteso, ricordando Hive – della tracklist è Vince Staples, artista poco versatile ma sempre capace di immagini efficaci e solida onestà, espresse da una voce ben riconoscibile. Wool è anch’essa costruita su poche note di piano e percussioni urgenti. Dopo temerarie allusioni di Vince agli omicidi a sfondo razziale, Earl predica fedeltà a OFWGKTA, rammentando che nonostante i giorni passati a fissare i soffitti grigi, è la sua strofa che tutti aspettano quando un pezzo si fa serio.
Il ragazzo dalle labbra gonfie si ritrae secondo linee tortuose degne di un Basquiat dell’era iPhone, ogni verso protetto da una saggia asocialità.
In appena mezz’ora, il numero di parole effettive dell’intero lavoro è molto minore rispetto alle due raccolte precedenti, ma esprimono tutte l’esatta nebbiosa tonalità di rassegnazione che vuole raccontare lui. I Don’t Like Shit è ancora più intimo se si considera il totale coinvolgimento di Sweatshirt nella produzione. Lui stesso, in un’intervista a NPR, ha dichiarato di concepire questo come il suo primo vero album, dove ogni cosa è al posto che gli piace (anche se la Columbia ha rovinato un po’ la sua sorpresa, lasciandolo giusto un po’ stizzito).
La realtà di colori esagerati in cui vive è complicatissima, un caos prematuro di ipercreatività.
Si tratta di un’opera estremamente comprensibile per chiunque abbia vissuto gli Alti e Bassi del tempo e abbia magari amato sentirsi raccontare la vita degli altri, trasformando la propria in un’intricata leggenda su cui scrivere fumetti, storie, poesie. Che ci si immedesimi o meno, ci si trova di fronte (e dietro, e accanto e ovunque) ad un personaggio sociologicamente e artisticamente troppo interessante per non attirare i più disparati tra i musicofili.
Rinuncia dunque a feature colossali e co-sign altisonanti (il primo album includeva Pharrell, BADBADNOTGOOD, il compare Frank Ocean e RZA del Wu-Tang), forse per crescere con calma, o perlomeno allentare la pressione. Pur volendo rimanere al buio e sentendo di appartenervi, Earl ci ricorda che non solo è un pensante, ma un lucido pensatore. Seppure con la visibilità e il hype di un album commerciale, ha dipinto un contesto in definitiva molto sperimentale.
Già ora da reputare uno dei migliori MC del periodo post-MyBeautifulDarkTwistedFantasy, presto potrà decidere se fare il salto di qualità, circondandosi di collaboratori giusti per un album che sia davvero un game-changer, e quante volte farlo in una carriera potenzialmente inarrestabile.
P.S. Proprio Alchemist ha condiviso, parole sue, una bonus track in tributo alle release di Action Bronson ed Earl, ricca di world sounds su ritmi colmi di black music, rappata magistralmente proprio dai due MC.




