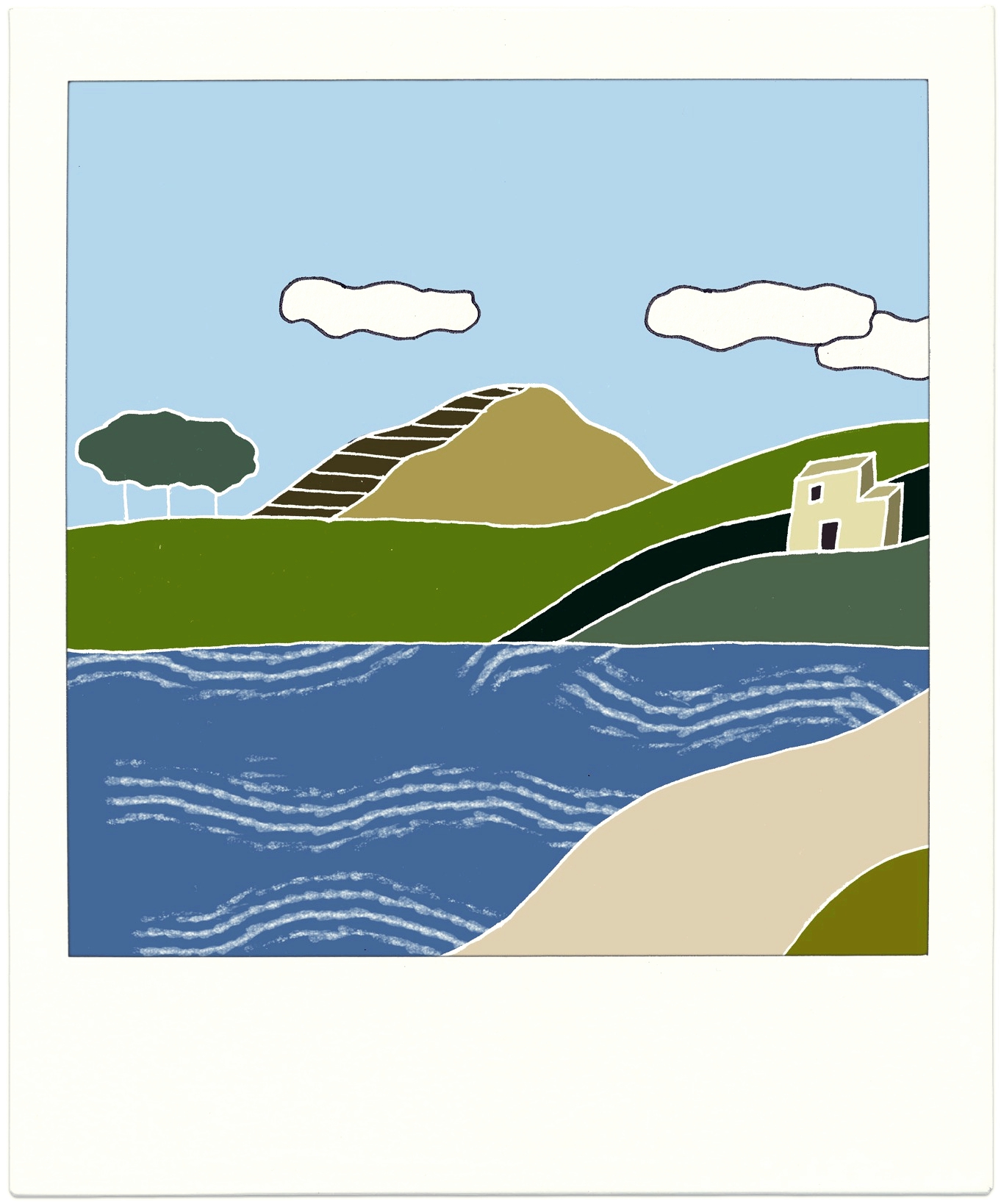
Al lago
Aspettami.
Ti seguo come l’ombra dei canneti che sfilano sulla tua maglietta bianca, faccio i passi più lunghi della mente ma quanto vai veloce. Piuttosto vorrei dis-correre, tra parole spezzate dall’affanno, alternare la destra, poi la sinistra in pari con la tua. Una marcetta di calzini colorati. Come si fa?
Ti lascio il vantaggio, quello che si dà in amore a chi fugge, e rallento, prendo fiato sulla staccionata con il lago che mi specchia: quanto mi fai sudare, ho le caviglie arrossate e i capelli che non stanno più nella coda.
Alla fine ci sto meglio lungo i bordi, nella periferia dei sentimenti, dove il lago esonda un po’, il canneto è finito e non ti vedo più. Nella poetica dell’amarsi un po’, meglio il niente: che io da te nemmeno l’ho voluto l’amore, figurati. C’ho perso
l’abitudine a volerlo.
E allora dimmi: che cosa mi manchi a fare?
Mi sento nel guado dell’inadeguatezza, un Intermezzo che attraverso con la paura di scivolare, di annegare. Trascinarsi è il verbo. E però Calcutta se mi urli “Ma non ci riesco più” io come faccio a ri-uscire? Mi metto in panchina, guardo gli altri corrersi insieme, quelli con i figli, quelli con le cuffie: che ascoltano, vengono spesso qui? Se dopo passi tu, possiamo immaginare. Ma quanto ci metti a ritornare.
Se chiudo gli occhi siamo seduti sulle foglie secche in una casetta di legno a guardare il cielo da fessure come i topi nei tombini, coi raggi di luce che ti tagliano le ginocchia spigolose appoggiate alle mie, una limonata che ci rovescia sul pavimento. Lo facciamo. Lo facciamo scricchiolare.
Ma la mia vita è come gli intermezzi, come le pause che si riempiono di vagonate di verbi al condizionale: ci vorrebbe una notte soltanto per viaggiare, per perderti nel bosco, per raggiungerti ora che ti sei fermato ad aspettarmi. Per ricominciare.
E tu quand’è che vieni? Ho ripreso a correre, ho fatto le braccia come i remi a cercarti in questo lago in lungo e in largo, a largo. Mi sembra un oceano di solitudine e io che ci barcollo dentro. Ti prego andiamo a Peschiera del Garda.
─ Claudia Maddaluno
[divider top=”no” divider_color=”#90c8a5″ link_color=”#90c8a5″ margin=”35″]

A Roma, martedì sera.
La scorsa settimana a Roma è arrivato il freddo e lo ha fatto esattamente come può arrivare il freddo a Roma: con un plotone di umidità pronta a conficcartisi sotto il cappotto.
Una sera ero a Monti a bere una cosa dopo il lavoro e ad un certo punto mi è presa una tale nostalgia del piumone che sono dovuta scappare prima ancora che la Magica facesse il goal della bandiera. Tornare a casa da Monti significa inerpicarsi fuori dalle stradine di quartiere, girare intorno a Sua Meraviglia Santa Maria Maggiore e prendere la linea A a piazza Vittorio. Non è nulla di proibitivo ma quella sera lì, con quel freddo lì sembrava difficilissimo.
Così ho cliccato play e sul telefono è partito il piano bar di Mainstream, il disco di Calcutta. Sì, piano bar, di quelli fumosi in cui i drink sono serviti con ghiaccio e nostalgia. È come una copertina che fa sembrare il freddo meno pungente e le luci lattiginose dei lampioni più simili a candele. Ci sono tante tastiere in questo disco, i riverberi e gli arrangiamenti scarni sembrano i live dei Camillas, il che, diciamolo, scalda il cuore. Già, perché se Pesaro è una donna intelligente il suo nome è senz’altro Camilla(s).
I racconti di Mainstream parlano di città attraversate a piedi agli orari più improbabili, di straniamenti culturali di fronte a quello che è ora il mondo (apro il giornale c’è Papa Francesco e il Frosinone in serie A), parlano di città troppo grandi e di campagne troppo lontane (preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso).
È un pop che dipinge una grande solitudine, quello di Calcutta, e della ricerca di una sponda nel mare di banalità del mainstream. A partire da Limonata, tra madri pellegrine, padri dai gusti banali e diete lunghe una vita che si rubano le energie anche solo per guardare il cielo. In una continuità musicale incredibile, quasi una fosse l’intro dell’altra, arriva la canzone più bella del disco, Frosinone, a parlare di spuntini solitari in città deserte, quando è troppo presto o troppo tardi e tutto ciò che si può fare è girovagare rimuginando di errori commessi nel cuore della notte.
Il brano che apre il disco, Gaetano, racconta di timidezze, di pretesti e di quanto sia difficile lasciarsi andare. Ha un sapore di friendzone dolorosissime ed è come se ci fossi nata dentro. Di Cosa mi manchi a fare non serve dire altro: con un titolo così, un video così e quel ritornello lì è diventata un classico nel giro di un mese e mannaggia se c’ha ragione!
Nel complesso passano veloci i metri e questa parte di Roma, deserta e assonnata, è un po’ meno fredda grazie ai racconti di Calcutta, che non è per niente male.
─ Cecilia Cioppy Cicolella
[divider top=”no” divider_color=”#90c8a5″ link_color=”#90c8a5″ margin=”35″]

Seduta sul tappeto, al centro del salotto.
Sto seduta sul tappeto in salotto, fuori la luce delle quattro di pomeriggio mi dice che è inverno e tra poco tutto finisce. Dentro io, a gambe incrociate al centro esatto della stanza, distante allo stesso modo da tutti gli angoli e gli spigoli, per non farmi male. Mainstream riempie tutto lo spazio che non riempio io.
Dopo pochissimo gli occhi mi si chiudono; schiaccio le palpebre fortissimo, nello stesso modo in cui sto stringendo le caviglie con le mani senza nemmeno accorgermene, sorrido piano per le risposte involontarie del mio corpo alle domande sottintese di Calcutta. Il sorriso è una parentesi se vedi bene, e io dopo la prima canzone la chiudo.
Provo a non pensare a me, immagino quelle statue ruvide con la testa un po’ inclinata di lato e senza le braccia che stanno nei giardini delle ville, a volte il tempo e il vento hanno fatto sparire anche i nasi, e mi chiedo se il posto dove sono nascoste tutte le braccia perse e pietrificate è lo stesso degli accendini, delle forcine per capelli, dei calzini sinistri e di tutte le mancanze.
Sento il tappeto pungermi le gambe nude ma rimango immobile anche durante Intermezzo 2.
Sto in apnea per non fare rumore e forse anche per smettere davvero di respirare mentre urla non ci riesco più così forte che mi si bagna la faccia di lacrime; mi sento una casa abbandonata, una poesia di Michele Mari, delle mani vuote. Mi arriccio i fili del tappeto tra le dita come se fossero i tuoi capelli scuri, questa canottiera bianca che indosso la vorrei alzare e sventolare come una bandiera, per dire che mi arrendo, che hai vinto tu disco nuovo di Calcutta, che non ho più difese né munizioni ma soltanto provviste e tabacco ancora per qualche settimana, per sopravvivere in trincea.
Se lo dici a voce alta, Medjugorje fa rima con De Gregori. (sorrisi che sono interferenze)
Sulla strada che da Borgo Roma porta a San Giovanni Lupatoto ci sono delle case vecchie con la vernice che si è scrostata dai serramenti e gli spazi rimasti vuoti dalle tegole che sono cadute, le piante del giardino sono rami di rovi intrecciati. Su una delle case tra la porta e la finestra c’è una scritta con la bomboletta rossa: ANNO GIA’ RUBATO TUTTO. Se dovessi spiegare come mi sento ora direi che mi sento così, un posto dove non è rimasto niente, nemmeno le acca.
p.s
volevo solo dire che nella canzone numero 2 del disco, quando Calcutta dice non mi importa se non mi ami più non è vero che non gli importa, gli importa eccome. E ecco, anche io delle volte quando dico “non importa” non è vero che non mi importa, mi importa eccome.
─ Valentina Rodella
[divider top=”no” divider_color=”#90c8a5″ link_color=”#90c8a5″ margin=”35″]

Lungo i canali di Gent
In Belgio, il tempo sa essere mutevole nei modi più imprevedibili e sorprendenti: ti ritrovi a passeggiare lungo i canali di Gent con il sole più splendente da mesi e il cielo limpido per poi essere investito da una pioggia incessante poche ore dopo, mentre intorno il paesaggio è sempre lo stesso. Il freddo – soprattutto – è sempre lo stesso. Cambiano i colori del cielo, cambiano le sensazioni sulla tua pelle, unica costante i guanti. Che poi Guanto era l’antico nome dato dagli italiani a Gent, e ogni volta mi fa ridere, tanto quanto Borsella per Bruxelles o Bruggia per Bruges.
In Belgio, impari a ripassare la geografia italiana ascoltando Mainstream e ad avere nostalgia di posti mai visitati, come Peschiera del Garda o Latina – città natale di Calcutta – ripensando a quella Pomezia cantata qualche anno fa, dove ci sposeremo dopo esserci incontrati a Venezia (mai visitata nemmeno quella). Il Frosinone vince contro il Verona mentre i figli di Molenbeek muoiono nel loro personale jihad e io torno a casa a guardare un film, perché fuori c’è l’allerta e restare a casa non è un atto di protesta ma un paradossale obbligo. Vorrei dirle ti presterò dei soldi per venirmi a trovare, ma forse non è aria. O forse sì.
In Belgio, l’Italia ti manca quando meno te l’aspetti e – negli occhi l’immagine di un bambino ciotto sul tram Termini-Giardinetti – le chiedi cosa mi manchi a fare, come se fosse una donna da cui vorresti ricevere risposte che non avrai mai. Una donna di cui potresti attirare l’attenzione facendo uno svastica in centro a Bologna. Una donna che forse è meglio lasciar andare.
Guardando le barche appollaiate lungo i canali di Gent, ti viene da sognare l’estate. Poi, però, sotto la pioggia, la malinconia riesce a strappare sorrisi. In fondo può essere bello crogiolarsi nelle proprie delusioni e nostalgie, soprattutto se ad accompagnarle ci sono un pianoforte pop, una voce bella nella sua stravaganza e improvvise botte drone che ricordano tanto certi risvegli domenicali post-Dal Verme al Pigneto, ma anche quelli di adesso post-Châtelain o Sainte-Catherine.
─ Livio Ghilardi
Tutte le illustrazioni sono di Mistobosco.





